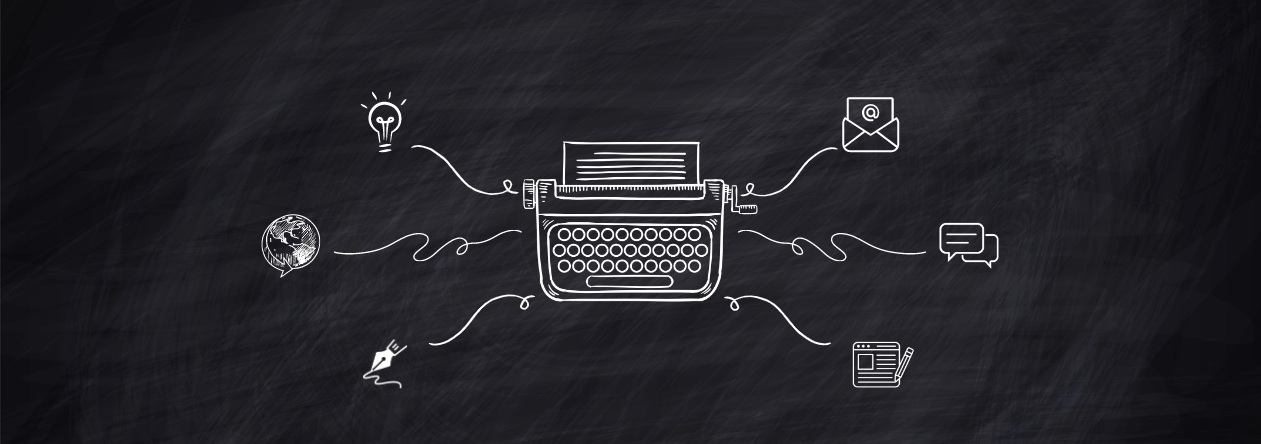Quest’anno ricorrono i 650 anni dalla morte di Giovanni Boccaccio, avvenuta il 21 dicembre 1375. La sua opera principale, il “Decameron“, ancora oggi ci parla con incredibile attualità.
Tra il 1349 e il 1353 Boccaccio compone il “Decameron”, una raccolta di cento novelle raccontate da dieci giovani, sette ragazze e tre ragazzi, che, per sfuggire alla peste, si rifugiano in una villa fuori Firenze. Qui, per dieci giorni, si alternano nel narrare storie che parlano d’amore, d’ingegno e di fortuna. Attraverso questi racconti, Boccaccio ci offre uno spaccato vivace sulla società del Trecento: le sue ipocrisie, le sue contraddizioni, le sue passioni. Ma soprattutto, ci offre un ritratto dell’essere umano con i suoi pregi e difetti, il tutto con uno stile brillante e un’ironia pungente che rendono il “Decameron” un capolavoro senza tempo.
Ogni storia raccontata dai giovani protagonisti è una finestra aperta sulla società medievale, che ne mette in luce vizi e virtù con una modernità sorprendente. La loro voce ci arriva limpida, come se parlasse ancora a noi lettori contemporanei.
Tra le novelle del “Decameron” si può ricordare quella di Lisabetta da Messina, che racconta un amore tragico e disperato. Lisabetta ama Lorenzo, ma i suoi fratelli, contrari alla relazione, lo uccidono. Scoperta la verità, la giovane dissotterra la testa dell’amato e la nasconde in un vaso di basilico, piangendovi sopra fino a quando, privata anche dell’ultimo ricordo dell’amato, si lascerà morire. Il racconto simboleggia l’amore soffocato dalla crudeltà e dalle convenzioni sociali, che conduce a una fine dolorosa e drammatica.

Si può ricordare poi la novella di Federigo degli Alberighi, protagonista di una delle storie più celebri della quinta giornata. Lui è l’incarnazione della generosità e del vero amore: un cavaliere che, per conquistare la donna che ama, spende tutte le sue ricchezze. Rimasto povero, si ritrova a vivere con il suo ultimo bene, un falcone. Quando Giovanna, la donna di cui è innamorato, si reca a pranzo da lui per cercare di salvare il figlio gravemente ammalato, Federigo, senza pensarci due volte, sacrifica il falcone per offrirle un pasto degno. Alla fine, il suo amore e il suo sacrificio vengono ricompensati: Giovanna si rende conto del suo valore e lo sceglie come marito. Si tratta di due storie d’amore molto diverse, ma che ci raccontano molto sui sentimenti, sulla società e sulle scelte che ogni persona deve affrontare.
L’eredità di Boccaccio dura da secoli. Il “Decameron” continua a essere studiato e letto non solo per il suo valore storico, ma perché è un’opera incredibilmente moderna. Le sue storie parlano di uomini e donne reali, con desideri, ambizioni e debolezze che ancora oggi si possono riconoscere nella società.
Inoltre il modo di scrivere di Boccaccio, la sua capacità di raccontare la realtà con leggerezza e profondità allo stesso tempo, ha influenzato intere generazioni di scrittori. Non si limita a raccontare storie, ma usa la narrazione per dipingere un’umanità viva e pulsante. La sua ironia non è mai fine a se stessa, ma diventa un mezzo per denunciare ingiustizie e ipocrisie, proprio come faranno molti scrittori nei secoli successivi. Da Geoffrey Chaucer a molti autori contemporanei, il “Decameron” resta un punto di riferimento per chiunque voglia raccontare l’umanità nella sua essenza più vera.
Dopo 650 anni, possiamo dire che Boccaccio è ancora qui tra noi. Le sue parole continuano a parlarci, a farci sorridere e a farci riflettere. E questo, forse, è il segno più evidente della sua grandezza.
DIANA AMALIA VISAN